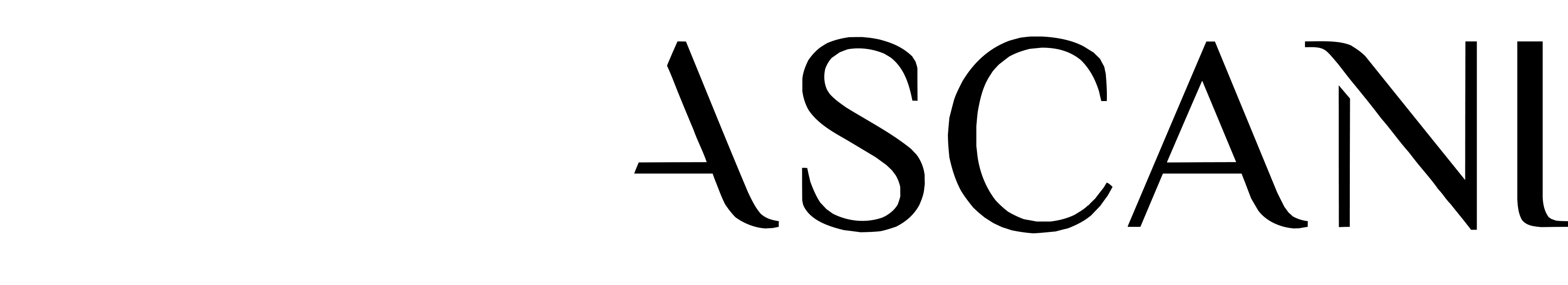dal mio blog su HuffPost Italia.
La parità di genere, le pari opportunità, la questione dei diritti delle donne tornano periodicamente centrali nel dibattito pubblico italiano. Capita in occasione del cinquantesimo anniversario del referendum sul divorzio o quando si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Capita a volte semplicemente perché una statistica rivela in modo impietoso il gap, la distanza, che esiste ancora tra i salari degli uomini e quelli delle donne, il numero di uomini e donne al vertice di aziende, di partiti politici, di istituzioni. O capita perché un fatto di cronaca ci porta a riflettere su quanto c’è ancora da fare perché in questo nostro Paese ci si possa sentire non uguali, ma pari.
Anche le recenti elezioni americane a ben vedere sono una buona occasione per discutere di questo tema. Diversamente da quattro anni fa, questa volta non c’era in campo l’ipotesi che una donna potesse diventare per la prima volta presidente degli Stati Uniti, rompendo molto più che un soffitto di vetro.
Sappiamo come andò con Hillary Clinton e sappiamo che le ragioni per cui quell’occasione è sfumata sono molteplici. Oggi però un’altra donna ha stabilito una “prima volta” nella storia americana: è Kamala Harris, figlia di un giamaicano e di un’indiana, competente, seria, empatica. In molti sussurravano che la sua figura avrebbe indebolito la campagna di Biden: lasciar pensare agli americani che se fosse successo qualcosa al presidente sarebbe toccato a lei assumere la guida dal Paese era secondo molti democratici un rischio, secondo i trumpiani una strategia comunicativa utile alla causa repubblicana.
È successo l’opposto, come certificano diversi approfondimenti e come hanno riconosciuto infine gli staff dei due candidati. Kamala Harris è stata un valore aggiunto e la vittoria di Joe Biden – avvenuta con circa 7 milioni di voti di scarto – è merito anche della sua Vice. Chissà se, nella loro prima intervista congiunta dopo la vittoria, avranno modo di parlare anche di questo.
Ovviamente non è tutto qui. Non si tratta solo della prima vice presidente donna degli Stati Uniti d’America. Potremmo certamente soffermarci sulla figura di Jill Biden, moglie del presidente eletto, la quale ha più volte detto di voler continuare col suo “day job” poiché, sostiene, insegnare non è semplicemente quello che fa, ma quello che è. Vedremo se gli impegni da First Lady – incarico che, contrariamente a quanto si tende a pensare da questa parte del mondo, comporta un bel carico di lavoro – glielo consentiranno.
Quello che più sorprende, però, è la quantità e la qualità delle donne che Joe Biden ha coinvolto e sta coinvolgendo ai vertici della sua amministrazione. Donne indiscutibilmente titolate e autorevoli.
Janet Yellen è certamente quella di cui si sta parlando di più. Già a capo della Federal Reserve (prima donna a ricoprire questo incarico) è ora chiamata a guidare il Tesoro americano nel mezzo di una crisi profonda determinata dall’impatto imprevisto e pesantissimo della pandemia. Il destino di milioni di americani è nelle mani del team economico di Biden si legge sul sito della CNN e quel team è guidato da una donna.
Che non è l’unica, però. Neera Tanden dovrebbe guidare l’Office of Management and Budget e Cecilia Rouse il Council of Economic Advisors. Ruoli delicatissimi e di grande responsabilità, tanto che le critiche, da destra e da sinistra, non si sono fatte attendere. E non solo l’economia sarà a guida femminile: anche la comunicazione (altro elemento chiave della politica americana) del presidente e della sua Vice saranno nelle mani di donne di grande competenza, sotto la guida esperta di Kate Bedingfield.
Insomma, l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca è senza dubbio una buona notizia per chi crede che avere più donne in ruoli di responsabilità all’interno delle istituzioni sia un ottimo viatico per rafforzare la presenza femminile ai vertici in altri settori e, di conseguenza, dare una spinta significativa sul piano delle pari opportunità e dei diritti.
C’è però un altro elemento che mi interessa sottolineare e che non è conseguenza diretta dell’onda blu che ha travolto Trump. Il centodiciassettesimo congresso degli Stati Uniti d’America vedrà un record di presenza femminile, 141 donne in totale, il 27% alla Camera e il 24% al Senato. Ancora poche, ma più che in passato.
Cori Bush, nota attivista del movimento Black Lives Matter, sarà la prima donna afroamericana eletta nel Missouri e Marilyn Strickland la prima coreana-americana del Congresso e prima rappresentante di colore dello stato di Washington. C’è poi Stacey Abrams che, sconfitta nel 2018 come candidata alla carica di Governatrice, è a quanto pare la vera anima della storica vittoria democratica in Georgia (lo Stato dal quale dipende anche il futuro equilibrio del Senato).
La notizia, però, è che anche nel fronte repubblicano sono diverse le donne che hanno battuto rivali democratici portando a un record anche il numero di donne repubblicane elette al Congresso. In molti indicano Elise Stefanik, 36 anni (nel 2015 è stata la donna più giovane mai eletta al Congresso) dello Stato di New York, come una delle maggiori responsabili di questo risultato a suo modo storico. Si tratta di una personalità molto discussa, anche per l’appoggio recente ma deciso alla battaglia legale di Trump sul risultato elettorale, eppure il supporto di una donna molto nota e molto in vista nel fundraising e nella campagna di altre candidate si è rivelato spesso decisivo, come alcune di loro hanno riconosciuto.
Donne che aiutano le donne. Così sei degli otto seggi strappati ai democratici dai repubblicani sono stati vinti da donne. Le biografie e le idee politiche di queste neoelette non piacerebbero a molti progressisti (tanto meno a me), ma quel che qui mi interessa rilevare è che l’elettorato statunitense sembra essere molto più aperto che in passato alla possibilità di farsi rappresentare da donne che ritiene all’altezza del compito. Vale per i democratici e per i repubblicani. Sembra scontato, non lo è. The times they are a‐changin’. Ed è una buona notizia.